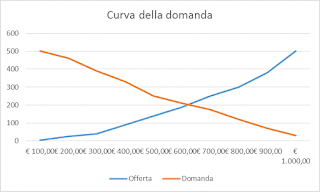Business e numeri, un tema già affrontato in un altro articolo di questo blog ("Qual è il miglior background per un CEO, numeri o vendite?"), ma che qui vorrei riproporre da una diversa prospettiva. Come si conciliano "crescita" e "profitto"? E, soprattutto, chi detiene le leve che determinano le priorità in azienda? L'assunto in questo articolo è che la differenza tra management e proprietà sia chiaro ed inequivocabile o che, quanto meno, la proprietà abbia una "naturale" tendenza a distinguere il ruolo in cui indossa il cappello del manager da quello in cui indossa quello del proprietario. Questa precisazione è fondamentale, perché se i ruoli non sono "tecnicamente" distinti, ogni decisione presa dal "padrone" è buona, anche se porta al fallimento l'azienda. Ma torniamo a bomba, si diceva, chi determina in azienda quando la crescita sta penalizzando troppo i profitti e quando, invece, una dilazione dei profitti è strategica per lo sviluppo? Normalmente, sono decisioni che si prendono in fase di pianificazione e la proprietà le sposa da subito o le rigetta, in base alle proprie considerazioni sulla redditività attesa. Ma, aziendalmente parlando, chi "governa" la gestione manageriale del tutto? Il CEO, naturalmente! Ossia colui o colei che ha ricevuto il mandato dal CdA per rendere effettiva la strategia nel corso dei 3/5 anni che ci si è dati per realizzarla. Ok, ma chi controlla che il CEO non si faccia entusiasmare troppo dalla progettualità e dalla prospettiva di medio termine, a scapito dei profitti da realizzare progressivamente? Il CFO, naturalmente! Sì, ma il CFO riporta al CEO e, quindi, può esprimere solo un parere fondamentale, ma non vincolante. L'alternativa è quella che il CFO riporti direttamente al CdA, ma in questo caso il CEO sarebbe una sorta di Medardo (Il Visconte Dimezzato).
Devo dire che negli anni ho visto molti CFO non prendere le giuste decisioni perchè completamente assoggettati al CEO. In qualche caso addirittura assecondando decisioni al limite della legalità. Ho anche visto, però, CFO riportare direttamente al CdA (o al loro capo europeo nel caso di multinazionali) ridotti a un mero organismo di controllo, che, a quel punto, sarebbe stato opportuno scollegare dagli obiettivi commerciali dell'azienda. Non è un affare semplice, soprattutto se si insiste nel vedere le due figure in contrapposizione di interessi che non possono, invece, che essere complementari. Personalmente, credo nella più ampia delega ai manager, quindi anche al CFO. Ma, mentre un direttore commerciale o un direttore marketing hanno un'indipendenza operativa che permette loro di prendere decisioni in tempo reale per il bene del business, il CFO ha una autonomia molto ridotta, in quanto "maneggia" numeri che "altri" producono. In altre parole, è messo di fronte all'evidenza dei fatti e agisce sempre di "rimessa". E' pur vero che le aziende più organizzate hanno procedure che permettono al CFO (spesso solo a valle) di intervenire per inibire iniziative che penalizzino eccessivamente il conto economico (sconti, ecc.) o il patrimonio (dilazioni di pagamento, ecc.), ma è anche vero che questo ruolo spesso ingenera conflitti in azienda difficilmente sanabili. Bisogna ricordare che la motivazione di un commerciale (anche in termini di bonus e incentivi) è, di norma, diametralmente opposta a quella del CFO. E' vero che tutti sono misurati sui profitti, ma con percentuali diverse. Ma il CEO in tutto questo cosa può fare? Cominciamo col dire che i giorni in cui il CFO era solo un macinatore di numeri sono lontani e finiti. E di questo il CEO ne deve tener conto. Tutte le attività commerciali devono essere valutate da subito insieme al CFO. Così come tutte le valutazioni in merito a profitti e patrimonio devono essere valutate da subito con il commerciale. Ecco il vero ruolo del CEO: incoraggiare e guidare la relazione dialettica tra se stesso e il CFO e tra le altre funzioni/divisioni aziendali e il CFO. Il CFO deve mantenere la sua autonomia di giudizio, ma deve conoscere la direzione strategica e di crescita dell'azienda. Per fare questo deve crescere e capire le dinamiche di sviluppo del business, per non limitarsi a conoscerle "solo" attraverso i numeri.
E questa attività è in mano al CEO, il quale deve arricchire la professionalità del CFO con la conoscenza della concorrenza, dei clienti, del contesto economico, ecc. Ovviamente, la stessa missione educatrice deve essere rivolta al commerciale e al marketing perché maneggino con padronanza tutte le tecniche di misurazione del payback della loro attività. Dialettica, dunque, tra chi gestisce la crescita e chi il profitto, pur partendo da posizioni antitetiche, ma con l'obiettivo comune e dichiarato di trovare la giusta sintesi di compromesso che sia difendibile sia sul fronte della crescita della quota di mercato, sia sul fronte della crescita o salvaguardia dei profitti. Resta inteso che il CFO è, a mio avviso, il braccio destro del CEO. Senza la bussola dei numeri ci si muove a caso, con quel che ne consegue. Ma è pur vero che se non si è chiari su chi governa la nave, magari creando "ruoletti" di controllo non ufficiale, si fa saltare in aria la "baracca". Come dice Mike Conform, CEO e CFO devono essere un duo dinamico e non "la strana coppia" e chiude dicendo: "There's often a difference between what you want to hear versus what you need to hear" (Spesso c'è differenza tra ciò che vuoi sentirti dire e ciò che hai bisogno che ti si dica).
Devo dire che negli anni ho visto molti CFO non prendere le giuste decisioni perchè completamente assoggettati al CEO. In qualche caso addirittura assecondando decisioni al limite della legalità. Ho anche visto, però, CFO riportare direttamente al CdA (o al loro capo europeo nel caso di multinazionali) ridotti a un mero organismo di controllo, che, a quel punto, sarebbe stato opportuno scollegare dagli obiettivi commerciali dell'azienda. Non è un affare semplice, soprattutto se si insiste nel vedere le due figure in contrapposizione di interessi che non possono, invece, che essere complementari. Personalmente, credo nella più ampia delega ai manager, quindi anche al CFO. Ma, mentre un direttore commerciale o un direttore marketing hanno un'indipendenza operativa che permette loro di prendere decisioni in tempo reale per il bene del business, il CFO ha una autonomia molto ridotta, in quanto "maneggia" numeri che "altri" producono. In altre parole, è messo di fronte all'evidenza dei fatti e agisce sempre di "rimessa". E' pur vero che le aziende più organizzate hanno procedure che permettono al CFO (spesso solo a valle) di intervenire per inibire iniziative che penalizzino eccessivamente il conto economico (sconti, ecc.) o il patrimonio (dilazioni di pagamento, ecc.), ma è anche vero che questo ruolo spesso ingenera conflitti in azienda difficilmente sanabili. Bisogna ricordare che la motivazione di un commerciale (anche in termini di bonus e incentivi) è, di norma, diametralmente opposta a quella del CFO. E' vero che tutti sono misurati sui profitti, ma con percentuali diverse. Ma il CEO in tutto questo cosa può fare? Cominciamo col dire che i giorni in cui il CFO era solo un macinatore di numeri sono lontani e finiti. E di questo il CEO ne deve tener conto. Tutte le attività commerciali devono essere valutate da subito insieme al CFO. Così come tutte le valutazioni in merito a profitti e patrimonio devono essere valutate da subito con il commerciale. Ecco il vero ruolo del CEO: incoraggiare e guidare la relazione dialettica tra se stesso e il CFO e tra le altre funzioni/divisioni aziendali e il CFO. Il CFO deve mantenere la sua autonomia di giudizio, ma deve conoscere la direzione strategica e di crescita dell'azienda. Per fare questo deve crescere e capire le dinamiche di sviluppo del business, per non limitarsi a conoscerle "solo" attraverso i numeri.
E questa attività è in mano al CEO, il quale deve arricchire la professionalità del CFO con la conoscenza della concorrenza, dei clienti, del contesto economico, ecc. Ovviamente, la stessa missione educatrice deve essere rivolta al commerciale e al marketing perché maneggino con padronanza tutte le tecniche di misurazione del payback della loro attività. Dialettica, dunque, tra chi gestisce la crescita e chi il profitto, pur partendo da posizioni antitetiche, ma con l'obiettivo comune e dichiarato di trovare la giusta sintesi di compromesso che sia difendibile sia sul fronte della crescita della quota di mercato, sia sul fronte della crescita o salvaguardia dei profitti. Resta inteso che il CFO è, a mio avviso, il braccio destro del CEO. Senza la bussola dei numeri ci si muove a caso, con quel che ne consegue. Ma è pur vero che se non si è chiari su chi governa la nave, magari creando "ruoletti" di controllo non ufficiale, si fa saltare in aria la "baracca". Come dice Mike Conform, CEO e CFO devono essere un duo dinamico e non "la strana coppia" e chiude dicendo: "There's often a difference between what you want to hear versus what you need to hear" (Spesso c'è differenza tra ciò che vuoi sentirti dire e ciò che hai bisogno che ti si dica).